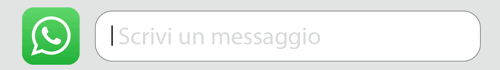C’erano molte aspettative su Hollywood, la nuova serie di Ryan Murphy per Netflix disponibile sulla piattaforma dal 1 maggio. Nonostante la qualità della produzione (ma ormai non ci si aspetta nulla di meno), qualcosa non convince e l’operazione di riscrittura della storia della Hollywood classica fallisce proprio sul finale con una chiusura sbrigativa e un eccesso di buonismo che ostacolano la sospensione dell’incredulità.
La trama
Nella Hollywood di fine anni ’40, quella dell’età dell’oro, si intrecciano le vicende di alcuni ragazzi di belle speranze alla disperata ricerca della propria fetta di celebrità. L’aspirante attore e veterano di guerra Jack Castello (David Corenswet) e l’aspirante sceneggiatore afroamericano Archie Coleman (Jeremy Pope) in attesa di una possibilità di entrare nel mondo del cinema sbarcano il lunario nella stazione di servizio di proprietà di Ernie West (Dylan McDermott), un affascinante uomo di mezza età che sognava di fare l’attore ma che è finito a capo di un giro di prostituzione maschile su cui si fondano i veri affari della sua “Golden Tip” gas station. Jack e Archie hanno un patto: il primo si occupa delle signore, mentre il secondo, che oltre a essere nero è anche gay (il che complica esponenzialmente le sue probabilità di sfondare a Hollywood) degli uomini.
Un bel giorno arriva nella città degli angeli per lavorare come attore il belloccio Roy Fitzgerald (Jake Picking), un gay timido e impacciato che si innamora subito di Archie. Roy viene notato dal potente agente Henry Willson (Jim Parsons) che gli cambia il nome in Rock Hudson e lo costringe a sottostare alle sue fantasie sessuali, oltre che a concedersi agli uomini di potere, con la promessa di renderlo una star. Intanto, nelle stanze dei dirigenti degli Ace Studios circola una buona sceneggiatura intitolata “Peg” e basata sulla vera storia di Peg Entwistle, la giovane attrice che nel 1932 si gettò dalla scritta Hollywood (allora Hollywoodland, sul Monte Lee sopra Los Angeles) dopo l’ennesima delusione inflittale dall’industria cinematografica.
La realizzazione di Peg viene affidata al giovane regista Raymond Ainsley (Darren Criss), metà americano e metà filippino, che ha una relazione con un’aspirante attrice afroamericana, la bellissima Camille Washington (Laura Harrier), e che sogna di cambiare l’industria di Hollywood per renderla più giusta e più inclusiva. Ora, si dà il caso che la sceneggiatura di “Peg” sia stata scritta proprio da Archie e che sia un’ottima sceneggiatura e che tutti, ma proprio tutti, desiderino lavorarci. Per farlo dovranno cambiare le regole del sistema e permettere a un’attrice di colore di interpretare per la prima volta il ruolo della protagonista in un classico film romantico rivolto a ogni spettatore d’America. Nasce così “Meg”, per la cui realizzazione ognuno dei protagonisti mette in gioco tutto quello che ha: reputazione, denaro e persino la propria incolumità.
Hollywood Dreamland
Intorno alla grande scritta sul Monte Lee la serie non solo concentra la storia del film la cui produzione rappresenta il tema centrale su cui convergono tutte le vicende, ma realizza anche una efficace, perché immediata, metafora sull’idea di ascesa, sulla scalata verso il successo, rappresentato dal simbolo più famoso di Hollywood, che è già tutta nella sigla iniziale. Se vuoi realizzare il grande sogno, devi prepararti a un’arrampicata faticosa e piena di ostacoli in cui ti giochi la vita a volte e la dignità ben volentieri a ogni piè sospinto. Ma una volta raggiunta la meta, puoi godere di un panorama mozzafiato e vedi il sole sorgere sulla città degli angeli che hai appena conquistato (e il resto del mondo con essa). La domanda è una: cosa sei disposto a fare per arrivare in cima?
Perché la serie può essere ingenua, e lo è dichiaratamente considerando che tutti sappiamo come è andata veramente (e che ancora oggi nel 2020 ci troviamo a lottare contro discriminazioni e pregiudizi), ma nel raccontare la cruda realtà di certe dinamiche su cui Hollywood si è costruita non lo è affatto.
Una delle cose più interessanti della serie è che essa punta il dito su una questione con cui non si è ancora fatto i conti: grazie al #MeToo le donne hanno potuto denunciare le molestie e le violenze subite da parte di certi uomini in posizioni di potere (probabilmente non è un caso che nel cast di Hollywood ci sia anche Mira Sorvino, una delle prime attrici a denunciare), ma non si parla ancora abbastanza di ciò che gli uomini di potere fanno e hanno fatto agli altri uomini. È intorno a questa questione che Ryan Murphy e Ian Brennan costruiscono la vicenda del giovane belloccio e di belle speranze arrivato dall’Illinois che presto diventerà Rock Hudson. Gli autori scelgono la storia emblematica di un attore notoriamente gay (notoriamente a Hollywood) che divenne un sex symbol per il pubblico femminile di mezzo mondo grazie all’abilità e alla potenza comunicativa dello star system.

Hollywood era una macchina perfetta per fabbricare star. Se un attore aveva il potenziale per diventare un divo, cominciava la trasformazione: dall’esercizio fisico all’odontoiatria, dalle diete severissime alla chirurgia plastica, anche una tortura medievale pur di passare gli screen test. Clark Gable aveva le orecchie a sventola e i denti brutti e Rita Hayworth l’attaccatura dei capelli bassa, divennero Rhett Butler e Gilda. Non intaccheremmo minimamente il fascino che ancora emanano dallo schermo se continuassimo a elencare i nomi di tutte le star e degli interventi a cui si sono sottoposti per diventare i miti che ricordiamo e ammiriamo: è la magia del cinema. E se il cinema è magia, Hollywood è Dreamland.
Ryan Murphy usa ironicamente questa parola come nome in codice nel giro di prostituzione gestito da Ernie West. Perché Hollywood è una terra dei sogni e una Babilonia allo stesso tempo. E la serie non esita a mostrare quello che gli aspiranti attori erano costretti a fare per diventare delle star. Le umiliazioni subite dall’ingenuo Rock Hudson gettato in pasto ai potenti dell’industria dal suo agente Henry Willson (un bravo e viscido Jim Parsons cui vengono affidate alcune delle battute più riuscite dell’intera serie) erano all’ordine del giorno, regole non scritte.
Ma su questo Ryan Murphy non ci dice niente di nuovo, quello che prova a fare è utilizzare un contesto ben noto (e ben raccontato in questa serie) per riscrivere la storia immaginando una Hollywood progressista e inclusiva che dimostra coraggio e lungimiranza nel produrre un film scritto da un uomo gay di colore, interpretato da una donna di colore e diretto da un regista per metà filippino, nel 1947.
Riscrivere la storia di Hollywood
Dimenticate la Hollywood democratica di oggi, quella che si oppone ai muri di Trump, quella del #MeToo e dell’#OscarSoWhite. La Hollywood di allora, nonostante alle feste succedesse di tutto (e nella serie si ha un bell’assaggio dei famosi party del sabato sera organizzati da George Cukor), era guidata da regole ferree e dallo stesso bigottismo che imperava nella società americana, materializzato e condensato nel famigerato Codice Hays. Un attore omosessuale non poteva dichiararsi, un’attrice di colore era condannata a ruoli da domestica e non si potevano mostrare sullo schermo coppie interrazziali.
Con Hollywood Ryan Murphy prova a costruire una storia diversa, anticipa a un’epoca in cui certi cambiamenti erano impensabili quello che successe solo molti anni dopo. Il superamento di ogni discriminazione, non solo verso le persone di colore ma anche verso gli omosessuali e le donne, è il faro che guida la scrittura di questa miniserie, ma paradossalmente finisce per essere il suo punto più debole quando gli autori si incaponiscono nello scioglimento di certi nodi e in certe svolte edificanti decisamente non necessarie.
I momenti migliori della serie sono invece quelli in cui i personaggi si rivelano nel conflitto, raccontando se stessi, il proprio passato e le proprie paure al di là del ruolo che ricoprono. E qui, nonostante l’ottimo livello del cast più giovane, sono gli attori di lungo corso che emergono, regalandoci interpretazioni meravigliose. Patti LuPone/Avis Amberg, Dylan McDermott/Ernie West, Holland Taylor/Ellen Kincaid e soprattutto Joe Mantello nella parte del produttore Dick Samuels costruiscono quei personaggi che, dopo un avvio di serie brillante, patinato e ritmato, donano spessore alla narrazione mostrando non solo il lato umano di Hollywood ma anche l’aspetto professionale, quello di un’industria resa grande anche dal lavoro appassionato e infaticabile di persone che la storia ha relegato nell’ombra.

La compresenza di personaggi realmente esistiti accanto a quelli di finzione è ormai un tratto caratteristico di molte creazioni di Ryan Murphy ma è anche, in questo caso, una delle scelte più riuscite della serie. La storia di Hattie McDaniel (interpretata da Queen Latifah), la prima afroamericana a vincere un Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Mami in Via col vento, che non poté assistere alla cerimonia e a cui fu permesso di entrare nella sala solo poco prima di ricevere il premio e quella di Anna May Wong (Michelle Krusiec), la prima star sino-americana ingiustamente relegata in ruoli stereotipati, regalano i momenti più commoventi di Hollywood. Perché lì sai di trovarti di fronte alla storia e questo contribuisce sempre a un maggior coinvolgimento emotivo nella visione. Si intuisce chiaramente il desiderio degli autori di rendere giustizia a chi è stato messo da parte perché ottusamente considerato diverso.
Conclusioni
Gli ingredienti per creare una magnifica serie c’erano tutti, soprattutto per il cast di grande livello e per la qualità della messa in scena, ma qualcosa non ha funzionato. Hollywood resta una piacevole visione, brillante, mai noiosa, una bella favola su come sarebbe potuto essere il cinema se fosse stato permesso a tutti di farne parte e di come questo avrebbe cambiato il mondo in cui tutti viviamo, rendendolo più giusto. Il problema della serie, a mio avviso, non risiede nell’ingenuità dei principi che ne hanno guidato la realizzazione, ché raccontare un sogno, immaginare un’altra realtà è pane per il cinema. Il problema è molto più tecnico e riguarda la scrittura degli ultimi due episodi e dell’ultimo in particolare, incomprensibilmente frettoloso e guidato dall’urgenza degli autori di risolvere ogni conflitto e di mettere tutto in ordine optando per scelte non solo inverosimili (ché tutto è inverosimile e questo non è un problema) ma fuori dalla logica della scrittura. Nel fare questo, gli autori dimenticano, e tradiscono persino, i personaggi a cui ci avevano fatti affezionare.
E alla fine, al termine dell’ultimo episodio, resta la sensazione che nella premura di raccontare la parte migliore del cinema, si siano dimenticati di utilizzarne il linguaggio come si deve.
Potrebbe interessarti anche: