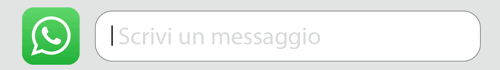Attualmente curatore della mostra “L’anima del Legno” dell’artista austriaco Herbert Golser al Castello Roveresco di Montebello d’Urbino, Riccardo Freddo è una delle voci più interessanti della scena artistica curatoriale contemporanea. Immerso in un’estate di intensa attività che lo ha visto protagonista di una serie di interventi artistici da Gradara a Perugia, Freddo porta avanti un percorso che intreccia paesaggio, memoria e arte contemporanea, costruendo dialoghi inaspettati tra i luoghi e le opere. Abbiamo colto l’occasione dell’inaugurazione della mostra di Golser per scambiare con lui due battute e farci raccontare la visione che muove il suo lavoro.
Negli ultimi anni si parla molto di arte come strumento di impatto sociale e rigenerazione. Qual è il tuo punto di vista? È solo un trend narrativo o può diventare una reale leva di sviluppo, anche economico?
È molto più di un trend narrativo. L’arte ha sempre avuto la capacità di incidere sulla realtà: di raccontarla, di metterla in discussione, ma anche di trasformarla. Oggi, in un’epoca segnata da fratture — sociali, ambientali, psicologiche — l’arte può e deve essere una leva di rigenerazione profonda, anche economica. Ma perché ciò accada, serve una visione sistemica. Serve investire nella produzione artistica come infrastruttura culturale, e non come decorazione o intrattenimento elitario. I dati parlano chiaro: in Italia l’arte contemporanea rappresenta solo l’1% del mercato globale. Ma questo dato può cambiare se iniziamo a lavorare sul lungo periodo, coinvolgendo amministrazioni locali, imprenditori, collezionisti, fondazioni e artisti in progetti di impatto territoriale.
Con The Place of Silence, la residenza d’artista che ho fondato in Umbria, sto sperimentando proprio questo: portare artisti internazionali in Italia, innescando dialoghi con la comunità e attivando processi di trasformazione culturale che hanno ricadute anche sul turismo, sull’economia locale, sul tessuto sociale.
Non è solo una questione ideale, è anche una questione strategica: i territori marginali possono diventare nuove centralità se sostenuti da politiche culturali intelligenti.
Uno sguardo al futuro: come immagini il ruolo del curatore nei prossimi dieci anni? Sarà ancora un ponte tra artista e istituzione, o dovrà diventare anche un imprenditore culturale a tutti gli effetti?
Il curatore del futuro dovrà necessariamente essere entrambe le cose: un mediatore sensibile tra artista e pubblico, e al tempo stesso un progettista culturale con competenze manageriali e visione strategica.
La figura del curatore “puro”, chiuso nella torre d’avorio della teoria, è ormai superata. Oggi curare significa saper leggere i contesti, costruire economie sostenibili attorno ai progetti, parlare con istituzioni e collezionisti, comprendere i dati, anticipare i cambiamenti, gestire risorse umane e finanziarie.
Personalmente, ho sempre cercato di coniugare la mia formazione artistica con quella economico-finanziaria, proprio perché credo che oggi sia fondamentale saper navigare entrambe le dimensioni.
In un’Europa in cui i principali mercati (UK, Francia) stanno vivendo una contrazione — come dimostrano gli ultimi report — la figura del curatore deve diventare catalizzatrice di valore: non solo culturale, ma anche produttivo.
In Italia, il potenziale è enorme. Abbiamo spazi straordinari, artisti brillanti, una storia ineguagliabile. Ma serve una nuova generazione di curatori che siano anche imprenditori culturali: capaci di attirare capitali, costruire reti internazionali, dialogare con il sistema economico senza perdere l’integrità intellettuale.

Una riflessione sul mercato europeo
Il calo del Regno Unito (-8%) e la perdita di slancio della Francia dimostrano che l’Europa è a un bivio. Se da un lato assistiamo a una contrazione dei mercati maturi, dall’altro emergono nuove aree d’interesse — penso all’Europa dell’Est, ma anche al Sud Italia, che ha tutte le potenzialità per diventare un nuovo crocevia culturale.
L’Italia, pur restando marginale nei numeri, ha un vantaggio competitivo unico: il suo capitale simbolico. Dobbiamo solo imparare a convertirlo in valore strategico. Non bastano le fiere o i bandi: serve una visione strutturata, in cui arte, territorio e impresa si tengano insieme.
Il mio lavoro oggi si muove proprio su questa linea sottile: creare progettualità solide, con radici nella cultura ma con un linguaggio comprensibile anche al mondo finanziario. Se vogliamo davvero ripensare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, dobbiamo iniziare a costruire un nostro modello, coerente con la nostra identità.